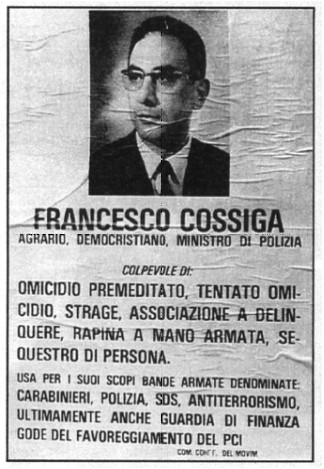|
Riappropriarsi
della storia, una storia vissuta in prima persona, è un modo per
documentare stati d’animo e pensieri, per informare le generazioni
future di un possibile verità su un periodo della nostra giovinezza
vissuta con tanto ardore ed entusiasmo soffocati da eventi forse più
grandi di noi.
Di fronte a tale obiettivo non dobbiamo lasciarci prendere da
sentimentalismi o ricordi fini a se stessi, ma prendere atto con
scientifica crudezza ciò che veramente sono stati gli anni
cosiddetti di “piombo”, in particolar modo l’anno 1977.
Le istituzioni
In quell’anno ci furono grossi mutamenti in atto nello stato e nei
partiti “statalizzati”. La politica era gestita da un governo delle
astensioni, cioè il monocolore democristiano a guida Andreotti ,
sorretto dall’astensione di tutti i partiti di quello che allora si
definiva l’arco costituzionale. Un governo nato dalle elezioni del 20
giugno 1976, il primo governo dopo il 1948, con il PCI non
all’opposizione.
Un sistema di democrazia “conflittuale” controllata, dovuta proprio
all’ingresso del PCI nel governo. Cosicché i dirigenti e i singoli
militanti del PCI si sono distinti per la difesa di ogni istituzione
statale, per la volontà di repressione di molte lotte, per la
asfissiante sollecitazione ai “sacrifici” rivolta ai lavoratori.
Il culmine del processo involutivo del PCI sarebbe stato rappresentato
dalla legislazione di emergenza che nel ’77 diventa la base
dell’accordo fra i partiti dell’arco costituzionale ed è stata la
condizione per la cooptazione del PCI nell’area democratica e di
governo: per la prima volta nella sua storia il PCI si è dichiarato
favorevole a un massiccio restringimento delle libertà e delle garanzie
costituzionali e si è impegnato in campagne ideologiche – ultima quella
del referendum sulla legge Reale – dirette ad alimentare consenso
popolare nei confronti del processo di restaurazione autoritaria.
ANDREOTTI G . Presidente del Consiglio
COSSIGA F . Ministro degli Interni
FANFANI A . Presidente del Senato
INGRAO
P.
Presidente della Camera
MALFATTI
Ministro Pubblica Istruzione
L’appoggio comunista alla politica del governo fa si che il
conflitto si concentra verso il PCI oltre che verso la DC e lo stato.
Tale scontro, nella sua applicazione concreta, ha prodotto centinaia di
morti e feriti e nella stragrande maggioranza dei casi decisamente
innocenti. E’ chiaro che si da alle forze di polizia l’impressione
dell’impunità, si legittima l’uso dispiegato delle armi.
La gestione dell’ordine pubblico si fa pressante ed univoco verso la
repressione di ogni contrapposizione al sistema. La legge Reale (1975)
è la prima legge eccezionale per la tutela dell’ordine pubblico,
chiamandola ordine pubblico costituzionale. Ciò significa ordine
gerarchico di una società pacificata nelle sue contraddizioni di
classe, attraverso militarizzazione e repressione feroce, portando di
fatto alla trasformazione dello stato di diritto in stato di polizia.
Per i poliziotti e carabinieri che uccidono non solo immunità della pena, ma addirittura immunità dal processo.
Ci sono grosse restrizioni contro chi manifesta il dissenso a tale sistema, ad esempio:
articolo 5 riguardante i manifestanti
<<E’ vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni
svolgentesi in luogo pubblico o aperto al pubblico facendo uso di
caschi protettivi o con il volto in tutto o i parte coperto mediante
l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il
riconoscimento della persona……..>>. Legge Reale
firmata da Leone , Moro, Gui. Nel febbraio del ’76 viene nominato
ministro dell’interno Cossiga dal governo presieduto da Andreotti
. A Roma il 2 febbraio ’77 vi è la prima apparizione dei poliziotti in
borghese delle squadre speciali di Cossiga .
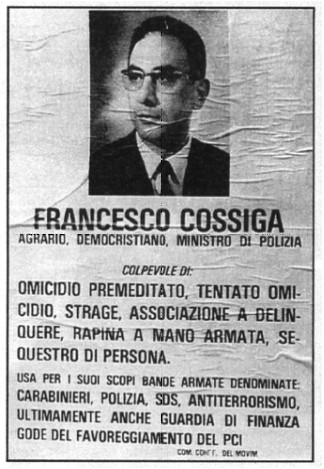
1977
Il quadro politico istituzionale si complica per effetto di un
importante elemento di scontro fra stato e studenti: alla camera la
commissione pubblica istruzione impegna Malfatti a sospendere a
tempi indeterminato la circolare sui piani di studio. La circolare
vietava agli studenti di fare più esami nella stessa materia, e
smantellava di fatto la liberalizzazione dei piani di studio in vigore
dal ’68. Il progetto prevedeva l’introduzione di due livelli di laurea;
la suddivisione dei docenti in due ruoli distinti (ordinari e
associati); la creazione di una gerarchia piramidali di organi di
gestione, dove ai professori ordinari era garantita la maggioranza; il
controllo rigido sui piani di studio da parte dei docenti, l’abolizione
degli appelli mensili e il raggruppamento degli esami in due sessioni
estiva e autunnale; l’aumento delle tasse di frequenza, restando
inalterato il fondo per gli assegni di studio.
5 febbraio ’77 primo divieto di manifestare.
15 aprile ’77 il progetto di riforma Malfatti viene approvato dal consiglio dei ministri.
La vita politica e soprattutto sociale si configurava per opposte
fazioni le quali necessariamente dovevano entrare in conflitto e quindi
non vi era possibilità di crescita se non ad un caro prezzo.
La Piazza
La contestazione studentesca inizia sostanzialmente con il ferimento di
Guido Bellachioma , studente del collettivo di Lettere dell’università
di Roma, durante un’incursione nella città universitaria da parte dei
fascisti del Fuan. A Lettere si discuteva della circolare
Malfatti e delle iniziative da intraprendere fra le quali
l’abrogazione della stessa , l’autogestione dei seminari, garanzie per
il no intervento della polizia nell’Università e creazione di un
servizio d’ordine contro le provocazioni.
Intanto si alza il livello di scontro ed aumentano le aggressioni in
varie parti della città, vi sono le prime avvisaglie della copertura
delle forze dell’ordine in fatti delittuosi da parte dei fascisti.
Un pomeriggio si tiene un presidio antifascista davanti all’istituto
Fermi, contro il comizio di Almirante a Monte Mario. Alcuni fascisti
della sezione del MSI di via Assarotti sparano contro i militanti di
sinistra sotto gli occhi della polizia che presidia la sede missina.
Verso le 17,30 alcune centinaia di giovani assaltano la sede del MSI.
La polizia spara ed alcuni giovani e dei passanti vengono feriti. Sul
posto vengono ritrovati 200 bossoli di pistola.
Intanto la protesta contro la circolare Malfatti si estende alle
scuole medie e molti istituti vengono occupati dagli studenti che
praticano l’autogestione. Le autogestioni impongono una presenza
costante negli istituti e ciò favorisce la vulnerabilità degli
occupanti di fronte alle incursioni dei fascisti.
Si registrano i primi assalti alle scuole; davanti al Mamiani due
giovani vengono feriti dai colpi di pistola di un commando fascista,
uno in modo grave; al liceo Augusto un gruppo di missini della vicina
sezione di via Noto aggredisce gli studenti con una fitta sassaiola.
Gli studenti di sinistra sono bersaglio continuo da parte dei fascisti
anche lontano dalle sedi scolastiche. Infatti a Roma, il 29 marzo, una
squadra di fascisti delle sezioni missine di via Ottaviano e Balduina,
va all’assalto di un ristorante frequentato da militanti si sinistra,
all’arrivo della polizia i fascisti si coprono la fuga sparando
raffiche di mitra, provocando il ferimento di un agente e di un giovane
di passaggio. Altri intanto trovano riparo in una chiesa di via della
Conciliazione, dal tetto sparano raffiche di mitra contro le volanti
della polizia. Vengono arrestati undici fascisti, tra cui il figlio del
giudice Alibrandi , che saranno rilasciati dopo pochi giorni.
Nel frattempo il ministro dell’interno Cossiga inasprisce i
provvedimenti sull’ordine pubblico fino a vietare a Roma le
manifestazioni per tutto il mese di maggio.
Il 12 maggio, nella ricorrenza della vittoria referendaria sul
divorzio, i radicali indicono una festa a piazza Navona a cui aderisce
anche l’assemblea dell’università e i gruppi della nuova sinistra.
Scoppiano gravi incidenti tra i partecipanti e la polizia, rinforzata
nell’occasione da squadre “speciali” di poliziotti camuffate da
manifestanti. La manifestazione viene attaccata a piazza Navona e a
Campo di Fiori. A ponte Garibaldi le squadre speciali cossighiane
uccidono Giorgiana Masi , studentessa di 19 anni del liceo Pasteur di
Monte Mario. Gli scontri durano fino a tarda notte, almeno quattro
manifestanti e un carabiniere vengono feriti da colpi di arma da fuoco.
Il 16 maggio Cossiga rivendica la legittimità delle squadre
speciali e nega che i poliziotti abbiano fatto usa delle armi, viene
smentito vergognosamente dalle foto e dai filmati che testimoniano
l’uso massiccio delle armi da parte sia dei poliziotti in divisa che da
quelli in borghese, quest’ultimi significativamente abbigliati come i
manifestanti; il questore stesso conferma la presenza di almeno trenta
agenti in borghese durante gli scontri.
|